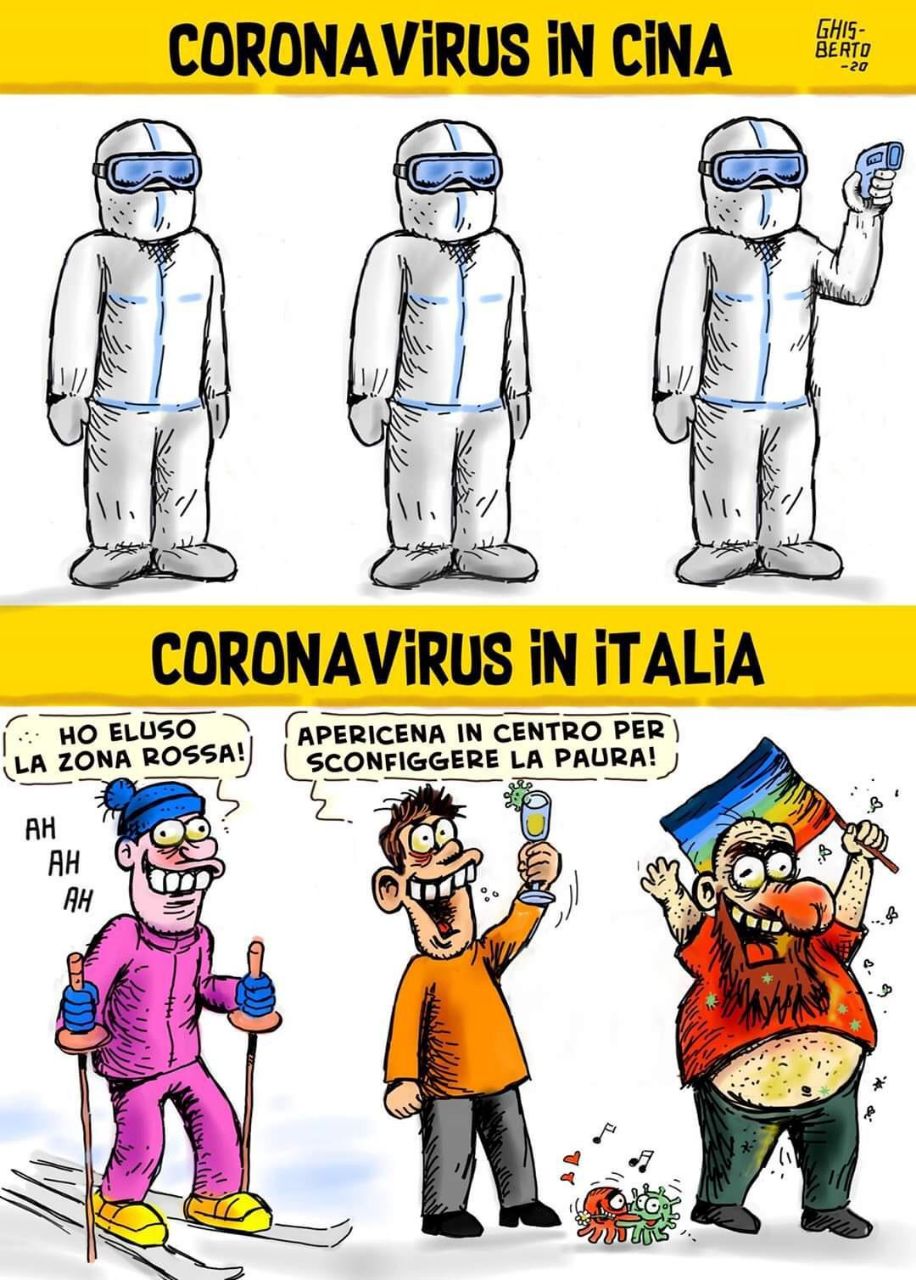Ai caduti di Modena,
nell’anniversario dell’uccisione
di Francesco Lorusso.
A est la luna piena abbagliante, a ovest Venere risplendente, a sud-ovest l’elicottero ronzante, a nord la nebbia che s’alzava dallo Scolo Calamosco e a sud il carcere della Dozza, con i colli e San Luca sullo sfondo.
Il carcere era in fiamme.
Erano le undici di sera.
Avevamo aggirato i posti di blocco su via del Gomito, imboccando stradelli che conosceva solo Wu Ming 2, ed eccoci in piedi in mezzo a un campo arato, a cento metri dalla recinzione del carcere. Eravamo visibilissimi, per via del plenilunio, ma le guardie avevano ben altro da fare.
Le scarpe appesantite dal fango, le mani impruriginite da qualche pianta urticante afferrata risalendo la ripa del canale. L’avevamo attraversato su una passerella di fortuna, una scaletta d’alluminio gettata di traverso.
Solo mezz’ora prima, nessuno di noi pensava di dover fare quel trekking notturno. Poi lo scatto: – Andiamo alla Dozza. Becchiamoci al volo in Bolognina.
Dal carcere saliva una tromba di fumo scuro, reso bronzeo dalle luci dei fari.
Qualche ora prima erano andate a fuoco due macchine della Penitenziaria.
Sagome nere sul tetto, urla: «BASTARDI!»
Spari di candelotti, clangori, forse colpi di piccone, qualcuno sfasciava barricate.
A fare da bordone, il rombo perenne della tangenziale.
Dietro di noi, curiosamente, c’era via del Bordone. Una sterrata piena di buche, che avevamo seguito fino a lasciare l’auto all’ingresso del podere La Chiocca.
– «Gran Sasso – Cucina abruzzese»? Mai avrei immaginato di trovare un ristorante sconfundato qui, in ze mìddol ov nóuer.
– All’incrocio, su via di Cadriano, c’è lo stabilimento Granarolo. Di giorno un po’ di giro c’è.
– Di sera è spettrale, però.
– Ma tanto adesso li han chiusi tutti, i ristoranti.
Entrati in un fondo di proprietà dell’Alma Mater, che ci faceva non precisate «colture sperimentali», e dopo avere incrociato un’enorme nutria albina, avevamo costeggiato lo Scolo Calamosco, poco più di un rigagnolo che fiatava nebbia densissima. Trovata la scaletta, eravamo passati di là.
Bologna, il carcere della Dozza in fiamme visto da nord-est, 9 marzo 2020, h. 23 circa. Foto di Wu Ming 4. Clicca per ingrandire.
– Non si vedeva una roba così da quarant’anni. Da Trani, nell’80, e Fossombrone, nell’81…
– Sì, «dall’Ucciardone / all’Asinara, / un solo grido: / compagno, spara!»
– Ma nemmeno negli anni ’70 ci sono mai state così tante rivolte in così tante carceri, in simultanea.
– Qui comunque va a finire brutta brutta… Quelli che gli va bene li storpieranno di mazzate.
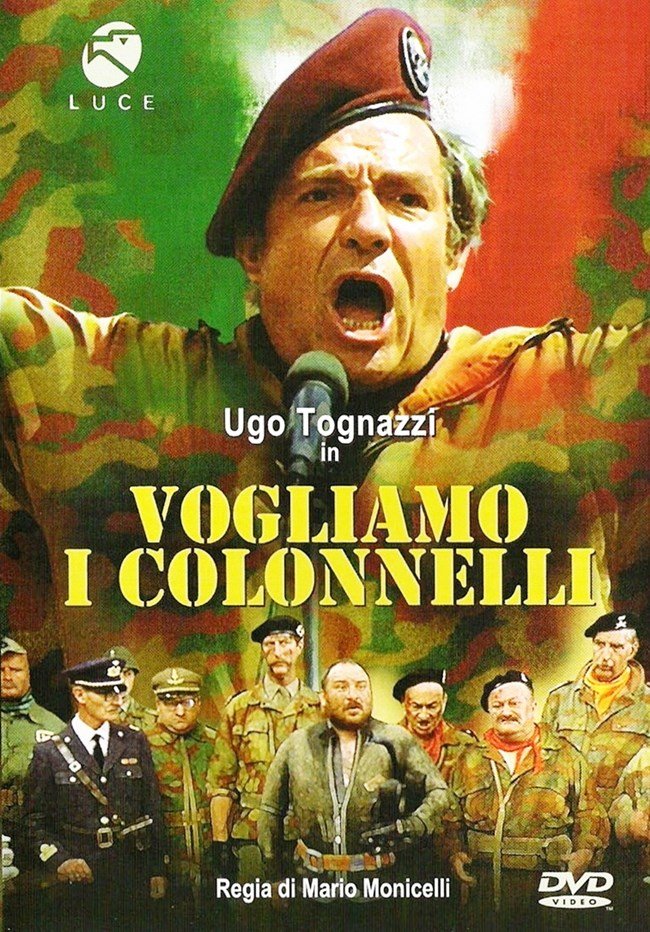 Un’ora prima l’ennesimo decreto aveva trasformato il paese intero in zona «a contenimento rafforzato». Ormai facevano un decreto al giorno, dopamina a balùs. Intossicati di brutto. Divieto assoluto di «assembramento», «#iostoacasa», «cambiamo abitudini», «#iostoacasa», tutti serrati in casa, dicevano popstar, rapper e trapolèr famosi e registi sorridenti con case immense ai Parioli e servitù. «Mostriamo responsabilità», «siamo tutti sulla stessa barca», «ce la faremo tutti insieme».
Un’ora prima l’ennesimo decreto aveva trasformato il paese intero in zona «a contenimento rafforzato». Ormai facevano un decreto al giorno, dopamina a balùs. Intossicati di brutto. Divieto assoluto di «assembramento», «#iostoacasa», «cambiamo abitudini», «#iostoacasa», tutti serrati in casa, dicevano popstar, rapper e trapolèr famosi e registi sorridenti con case immense ai Parioli e servitù. «Mostriamo responsabilità», «siamo tutti sulla stessa barca», «ce la faremo tutti insieme».
«Tutti insieme», ma contro i detenuti «non escludiamo di usare l’esercito». Loro mica sono sulla nostra barca. L’esercito. Vogliamo i colonnelli. Con Tognazzi.
– Visto come succede? Zac, e da un’ora all’altra non puoi più lasciare il paese.
⁂
Non scrivevamo più nelle biblioteche. Ormai avevano chiuso anche quelle. Non c’era più un posto dove mettersi, a casa c’erano i cinni e mille distrazioni, e così scrivevamo dove capitava: nei parchi dove c’era un po’ di wi-fi, sui gradini di San Petronio… Anche nella sala d’aspetto della stazione, quella con la breccia della bomba dell’80. Finché restava aperta.
Ci passavamo spesso, alla stazione, e una sera avevamo visto transitare convogli pieni zeppi diretti a meridione. «Folla sui treni per lasciare Milano», avrebbero titolato i giornali.
Da poche ore circolavano le bozze di un nuovo dpcm (decreto della presidenza del consiglio dei ministri). Cos’era, il quarto in una settimana? L’annuncio repentino che l’intera Lombardia e svariate province del resto dell’Alta Italia sarebbero diventate zone rosse – poi virate in «arancione» – aveva scatenato il fuggi fuggi, assembramenti ai binari, e in generale un rapido spargugliarsi di migliaia di persone sul territorio nazionale.
«Inaccettabile confusione causata dalla diffusione delle bozze del decreto», aveva detto il premier Conte. Si dava la colpa a un whistleblower. Una petizione lo individuava nel governatore Fontana e/o nel portavoce della pcm Casalino, e per non sbagliare chiedeva le dimissioni di entrambi.
Il potere e i suoi zelanti sostenitori si lamentavano che il «popolo bue» fosse stato informato prima anziché dopo, e che avesse capito e reagito «male».
Ma il caos non lo aveva scatenato il leak: lo aveva scatenato il testo stesso del decreto. E chi mai, potendo ancora andarsene e avendo un posto dove andare, avrebbe voluto restare intrappolato in una specie di grande lazzaretto?
[Rispondere con sincerità, per favore: senza infingimenti né pose da cittadini ligi o da forcaioli a misura di social.]
Inoltre, non era questione di «bozze» o «fraintendimenti»: anche il testo definitivo era – per dirla coi governatori delle regioni dipinte d’arancione – «pasticciato», «ambiguo», «di dubbia interpretazione e difficile applicazione», deciso e scritto «senza un confronto preventivo» ecc. Quanto alle misure che si capivano, erano «esagerate» e «senza una ratio», aveva detto Zaia, riferendo il parere negativo del comitato scientifico di cui si avvaleva la regione Veneto.
Intanto, il Viminale se la prendeva con le regioni, accusandole di muoversi alla spicciolata. Non quelle dove c’era il «contenimento rafforzato», ma tutte le altre. Alcune regioni del centro e del sud avevano annunciato la quarantena per chi veniva dalle zone a rischio, altre no.
Il governatore della Puglia Emiliano aveva criticato i revenants suoi corregionali, lagnandosi dell’«esodo» che portava a sud l’«epidemia lombarda» (sic).
Ma l’esodo non era cominciato la sera prima: era in corso da settimane, semplicemente con meno intensità e in modo meno visibile, perché ogni restrizione decisa in fretta e furia – e applicata senza la minima chiarezza – aveva aumentato la mobilità.
La fuga dal centro-nord era iniziata con le prime ordinanze regionali ed era proseguita senza interruzioni.
Molti precari, rimasti senza lavoro e non avendo ammortizzatori di alcun genere, erano tornati dai genitori, al sud o comunque sotto la linea gotica, dove almeno un piatto di minestra sapevano di rimediarlo.
– Non ho capito: dovevo fare la fame per accontentare Burioni?
Con gli atenei chiusi, anche molti studenti fuorisede erano ripartiti. Tanto, senza luoghi di socialità e cultura, senza musica e senza cinema, in città non c’era un cazzo da fare. Qualcuno se n’era andato già dopo la prima ordinanza, dopodiché, di restrizione in restrizione, la vita quotidiana si era fatta penosa e l’esodo era aumentato: bar, osterie e ristoranti chiusi dopo le 18; vietate persino le esibizioni degli artisti di strada…
– Non posso manco studiare, hanno chiuso le biblioteche. Che ci resto a fare in ‘sta città morta?
♫ Bulåggna che stai sotto la collina,
distesa come un vecchio addormentato,
la noia, l’abbandono, il niente
sono la tua malattia.
Bulåggna, ti lascio, io vado via.
Per due giorni Bulåggna era rimasta una specie di isola, parte di un arcipelago che includeva Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. A ovest la zona arancione cominciava dopo Anzola, a est Rimini era già dannata. La via Emilia interrotta da checkpoint e confini presidiati: non accadeva dal settembre del ’44.
Poi, in capo a due giorni, ci eravamo dannati anche noi, con tutto il Paese.
Nowhere to run anymore.
In Emilla-Romagna c’erano 75 persone ricoverate in terapia intensiva. Settantacinque in tutta la regione, e si diceva che la nostra sanità, fino a ieri «eccellenza», «fiore all’occhiello» ecc., era sull’orlo del collasso.
Ok, bisognava tener conto della crescita esponenziale, nel giro di una settimana potevano diventare 250, ma quello era il classico ragionamento di chi dà la colpa «alla Natura» per le distruzioni di un sisma, senza tener conto di come s’è costruito, di come s’è conciato il territorio.
A forza di chiudere ospedali, una regione di quattro milioni di abitanti s’era ridotta ad avere poche decine di posti-letto e ventilatori per affrontare l’epidemia.
Meglio andare con ordine, però. Sulla sanità, dopo.
⁂
Il mondo del lavoro era stato gettato nel caos. I decreti governativi imponevano la distanza di un metro sui luoghi di lavoro e lo smart working per chi poteva lavorare da casa. Questo creava una discriminazione evidente: c’era chi veniva messo in sicurezza e chi no.
La campagna comunicativa era ossessionante: «Restate a casa, non siate incoscienti!». Ma chi lavorava nei front office, chi mandava avanti gli uffici pubblici e i servizi, o rimaneva alla catena di montaggio, iniziava a sentirsi quello a cui era toccata la pagliuzza corta, e minacciava di mollare tutto. Cosa sarebbe successo se uffici e fabbriche non avessero più funzionato?
Intanto, la chiusura di palestre, centri sportivi, scuole, cinema e teatri aveva messo a casa una miriade di lavoratori autonomi o parasubordinati, che per le caratteristiche contrattuali faticavano ad avere accesso agli ammortizzatori sociali. I sindacati di base chiedevano il «reddito di quarantena», cioè misure di sostegno al reddito di tutti i cittadini, fossero lavoratori dipendenti, precari, autonomi, partite IVA, operatori sociali, lavoratori dello spettacolo ecc.
I lavoratori messi a casa scrivevano disorientati e disperati ai sindacati anche solo per sapere cosa fare:
«Salve,
vi scrivo per segnalare la perdita del periodo lavorativo corrispondente all’emergenza coronavirus.
Una delle società per cui sono responsabile di settore mi corrisponde €250 al mese. L’altra – una scuola dove insegno 15 ore a settimana – me ne corrisponde 300.
Per tutta la durata dell’emergenza non percepirò il compenso pattuito.
È una situazione che ci mette in ginocchio. Io ho famiglia e figli. Non è possibile essere trattati così.
Aiutateci. Grazie.»
Erano decine e decine le mail e le telefonate di quel tenore che riempivano le caselle postali e le linee delle Camere del Lavoro.
Dopo anni e anni di desindacalizzazione, emorragia di tesseramenti, disintermediazione, all’improvviso la gestione delle conseguenze dei decreti statali ricadeva sui “mediatori” sociali. Questi si ritrovavano impegnati all day long nell’attivazione delle casse integrazioni, anch’essi impreparati a reggere una valanga di quella portata, e a loro volta intralciati dalle ordinanze, che imponevano la distanza e il contingentamento degli ingressi. Anche loro rischiavano il collasso.
Lo stato emanava decreti draconiani – confusi e incoerenti – e il paese reale doveva interpretarli, tradurli, renderli sostenibili.
Ammesso che fosse possibile.
E non lo era.
⁂

Silvio Brusaferro
L’1 marzo il presidente dell’Istituto superiore di sanità Brusaferro aveva dichiarato:
«Se entro i prossimi sette giorni i contagi scenderanno vuol dire che le chiusure e le misure prese hanno funzionato.»
Di giorni ne erano passati dieci e tutti erano d’accordo: i contagi erano in rapido aumento. Rapidissimo. Tanto che «non c’è più tempo», aveva detto Conte annunciando la chiusura dell’Italia intera. Salvo poi lamentarsi, come sempre, che il popolo non aveva capito, perché s’era precipitato a fare scorte. Ma se mi dici «non c’è più tempo», che debbo capire io?
Per la precisione, in aumento erano le diagnosi positive: il numero reale di contagi – visto che la maggioranza si beccava il Covid-19 in forma asintomatica o lieve e nemmeno si faceva il tampone – non lo conosceva nessuno.
Ad ogni modo, stando alla proposizione condizionale di Brusaferro, si poteva concludere questo: le misure non avevano funzionato.
Del resto, alcune le avevano decise a dispetto dei pareri negativi degli esperti. Il 4 marzo, il comitato scientifico che prestava consulenza al governo aveva detto: chiudere le scuole adesso e per due settimane sarebbe di dubbia utilità. Parere ignorato dal governo, uscito sui media ma immediatamente affogato nel clamore, per esser presto dimenticato.
Ma non si trattava solo di inutilità: era plausibile che le ordinanze e i decreti fino al penultimo, aumentando gli spostamenti delle persone, avessero in realtà esteso il contagio.
Dunque cos’era rimasto da fare, secondo la logica da rotolone lungo il piano inclinato, se non dichiarare l’intera Italia zona «protetta»? Per questo il nuovo decreto, a sole 48 ore dal precedente.
Secondo il team dell’Istituto Sacco e dell’Università di Milano che studiava il virus Sars-CoV-2, quest’ultimo girava in Italia almeno da gennaio, mentre il primo decesso collegato al Covid-19 era del 21 febbraio.
Se era vero, allora le misure di contenimento erano tardive e dunque, anche fossero state più coerenti e la loro applicazione meno cialtronesca, sarebbero servite a poco. Che la tempistica fosse la chiave dell’efficacia lo dicevano diversi studi scovati e passati in rassegna da Mauro, e anche accreditati siti di informazione scientifica, come Medbunker:
«Punto fondamentale di tutte queste misure è che vanno applicate appena possibile, subito. Un ritardo può renderle meno efficaci o completamente inutili.»

Si parlava di lui.
In Italia, nel periodo da dicembre (esplosione dell’epidemia a Wuhan) al 21 febbraio, cosa si era fatto? Non era tanto difficile intuire che, prima o poi, l’epidemia di Covid-19 sarebbe uscita dalla Cina. E in ogni caso, era un’eventualità alla quale prepararsi.
Invece ci si era crogiolati nella disinformazione e nell’autocompiacimento orientalista. Più o meno: «Guardate i cinesi, si credevano stocazzo e adesso muoiono come mosche!». Per il resto, giornali e tv – come sempre – avevano rigurgitato scemenze, ruttato gossip, reiterato gare di cucina e ruminato la solita politichetta di infimo cabotaggio. Pagine e pagine, ore e ore e ore di talk-show a mostrare la buzza di un miracolato come Salvini o commentare le bizze di un has-been come Renzi.
Il 21 febbraio «La Stampa» faceva ancora battute sul “virus” della politica italiana e in prima pagina c’erano insulsaggini su Renzi. Il giorno dopo, tutti i giornali avrebbero aperto a cinque colonne sul primo morto di Covid-19 in Italia.
Come aveva ben riassunto Girolamo De Michele,
«se invece di strepitare istericamente sulla chiusura delle frontiere quando – ora lo sappiamo con certezza – il virus era già in Italia (e non lo avevano portato i cinesi) si fossero per tempo rafforzati i presidi sanitari, partendo dalla constatazione che il virus non sarebbe rimasto confinato nella provincia di Hubei, è probabile che quello che è stato considerato un picco di polmoniti da influenza stagionale sarebbe stato riconosciuto nella sua vera natura. Se fossero stati predisposti, come in Cina, adeguati ricambi al personale medico, evitando turni stressanti che sono la norma e che hanno offuscato la capacità di riconoscere l’improbabile dietro il consueto; se i primi pazienti fossero stati, oltreché identificati, ricoverati in ambienti idonei; il virus non avrebbe avuto una diffusione epidemica.»
Dopo la prima morte, in sole ventiquattr’ore si era passati dal regime della cazzata al regime della paranoia.
E purtroppo il caso del 38enne di Codogno – il «Paziente Uno» – aveva funzionato da diversivo, disperdendo l’attenzione in troppe direzioni, distogliendola dal fatto che tutte le altre vittime erano anziane e/o già indebolite da altre patologie. Ogni volta che lo facevi notare, qualcuno ti rispondeva: – E allora il 38enne di Codogno, eh?
Se constatavi che l’89% per cento dei morti era sopra i 70 anni, il 58% sopra gli 80, e nel complesso l’età media era 81, ti accusavano di «fregartene se muoiono i vecchietti». In rete, svariati post e commenti di imbezèl ci accusavano di questo.
Al contrario, quei dati – lampanti com’erano – avrebbero dovuto far capire che gli anziani andavano protetti in special modo, senza disperdere energie e diffondere paranoie, informandoli subito e adeguatamente. Qualcosa tipo: – Nonno, la situazione è rischiosa, per un po’ senti i nipoti per telefono e aspetta ben che passi la buriana.
Messaggio a tutta prima simile ma in realtà ben diverso dal generico, tardivo e terrorizzante «Anziani chiusi in casa!» risuonato che ormai eravamo a marzo.
Come avevamo scritto nel Diario virale #2, ci sarebbe stato bisogno subito di
«corretta informazione, unita alla capillarità dell’assistenza e a elementari misure di profilassi nella routine quotidiana, […] intervenire sulle esigenze dei più vulnerabili – principalmente anziani e immunodepressi – e potenziare le strutture ospedaliere che potessero accoglierli.»
Se l’obiettivo era «non far collassare la sanità», allora si sarebbe dovuto agire sui soggetti più a rischio, e intanto premunirsi aumentando i posti-letto in terapia intensiva, comprando nuovi ventilatori ecc.
Invece tutti i provvedimenti – chiusura dei luoghi di studio e cultura, poi dei luoghi di lavoro, poi di intere province e infine, in un crescendo di panico, dell’intera nazione – erano stati massimalisti e generici, e avevano avvelenato la vita sociale, diffondendo la paura del prossimo, il sospetto verso i rapporti umani, il desiderio di ulteriori misure securitarie.
Per due settimane la regione Emilia-Romagna aveva tenuto chiuse le scuole ma non i centri anziani. E così, sedici dei nuovi ammalati s’erano passati il virus nella stessa bocciofila. Se era aperta, normale che qualcuno pensasse di poterci andare, no? Se non volevi che ci andassero, dovevi chiuderla, no?
Ma le autorità, lungi dal fare autocritica, si erano messe a colpevolizzare gli anziani. Era partito il mantra: «Gli anziani a casa!».
Mantra inutile, perché era una toppa ipocrita messa sul buco di prima, e perché era un’ingiunzione vuota, come se negli anni di massima diffusione dell’Aids ci avessero detto tout court: – Non dovete chiavare! NON chiavate!
Mantra controproducente, perché inibiva anche condotte che invece sarebbero state salutari. Come nell’apologo raccontato su Giap dall’utente Vecio Baeordo:
«Ieri mia madre, che è ampiamente nell’età a rischio, mi ha detto: “Sarei uscita volentieri, sto bene, non faceva freddo e come sai ho tanto bisogno di camminare, ma dicono di stare chiusi in casa e ci sono rimasta”. Non sarebbe andata in birreria, e nemmeno al supermercato (ci vado io per lei), sarebbe andata a prendere una boccata d’aria, a muovere i muscoli e a far circolare un po’ il sangue. Zero contatti. Zero aumento rischio contagio […] Siamo partiti da un virus e siamo arrivati a un Generico Babau che sta “là fuori”. Un nemico invisibile ed esterno. Tecnicamente una paranoia.»
Finalmente, al TG1 delle 20 dell’8 marzo, uno scienziato senza aspirazioni sbirresche, l’infettivologo Massimo Andreoni dell’Università di Tor Vergata, l’aveva detto chiaro:
«gli anziani non devono restare confinati notte e giorno, è importante anche per loro uscire e svagarsi, magari non frequentando luoghi affollati, ma una bella passeggiata non può fare che bene.»
Nel frattempo, proprio lì a Bulåggna, un paziente proveniente dal piacentino, con la tosse, era stato ricoverato in Urologia per un intervento, senza problemi, nessuno gli aveva chiesto niente… e avevano dovuto chiudere l’intero reparto, perché solo dopo giorni s’erano accorti che aveva la febbre da Covid-19, non da decorso post-operatorio. E i pazienti di Urologia erano stati ricollocati altrove.
L’episodio faceva capire bene su quale genere di prevenzione/informazione si sarebbe dovuto puntare – triage all’ingresso delle strutture sanitarie, procedure diagnostiche mirate, potenziamento delle strutture ecc. – e su quale invece ci si era incaponiti a insistere: – NO interazioni sociali! State A CASA! #IOSTOACASA!!!
Ma quando politici e influencer intimavano «a casa!», quali case avevano in mente?
Le loro, a quanto pareva.
A leggere le disposizioni sulle misure di contenimento, sembrava che ciascun italiano avesse una stanza tutta per sé dentro una casa spaziosissima, e ovviamente ciascuno avesse un bagno separato.
Nel decreto del 7 marzo, per esempio, c’era scritto che chi aveva i sintomi doveva «rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale».
Ammalato o meno, chi restava in casa passava il tempo davanti alla tv, ad alimentare il proprio terrore, o sui social, dove ci si aizzava e impauriva e caricava la molla a vicenda, commentando gli annunci sempre più ansiosi e ansiogeni, facendo reload per aggiornare la “partita doppia” dei morti e dei guariti.
 Numeri sciorinati minuto per minuto come fosse una partita a basket Italiani contro Coronavirus.
Numeri sciorinati minuto per minuto come fosse una partita a basket Italiani contro Coronavirus.
Numeri decontestualizzati e perciò inutili a farsi un’idea sensata della situazione, come nel 2011 con l’aumento del misterioso «Spread».
Whatsapp era l’arma che aveva fatto più danni, di gran lunga il più potente amplificatore di paranoia. Messaggi vocali proliferanti parlavano di «ventenni intubati», uno era attribuito a sanitari del Niguarda di Milano. L’ospedale aveva smentito. Una bufalazza, giusto per alimentare il terrore. «Una menzogna e una porcheria inqualificabile», aveva detto il primario del San Raffaele, aggiungendo:
«Noi abbiamo 27 persone in terapia intensiva, sei sono guariti e ce n’è uno di 18. Ma uno. E capita anche in periodi normali che un giovane possa ammalarsi di polmonite. L’età media dei pazienti è 70 anni.»
Ma c’era poco da smentire, perché i social giocavano di rimessa. Il problema era il circolo vizioso tra politica e informazione mainstream.
Se si fosse continuato a parlare solo di contagi e morti e zone rosse, la paranoia avrebbe continuato ad autoalimentarsi e a produrre mostri e decreti-mostro sempre più assurdi.
Anche perché i politici reagivano sempre peggio e con meno lucidità man mano che scoprivano di essere positivi al test.
Era come se al governo ci fosse re Julian, quello di Madagascar.
– Nel secondo film vuole offrire Melman la giraffa in sacrificio al vulcano, per far finire la siccità.
– Ecco, uguale.
Era indispensabile allargare il campo dei discorsi e dell’analisi, oltre la risposta codina «Qualcosa devono pur fare!»
⁂

In un mese e mezzo di emergenza, delle carceri se n’erano fottuti tutti, come di altre realtà di sovraffollamento coatto, tipo CPR, dormitori e centri d’accoglienza.
Da anni la situazione nei penitenziari, sovraffollatissimi, era gestita sul filo del rasoio. Con l’emergenza, le condizioni di vita erano ulteriormente peggiorate, anche per via di restrizioni iper-zelanti e ingiustificate, misure improvvisate che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti aveva definito «frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre crescente che non trova fondamento né giustificazione sul piano dell’efficacia delle misure.»
La tensione cresceva da settimane. L’associazione Antigone aveva cercato di farlo capire, e avanzato proposte di buon senso, restando inascoltata.
Finché non erano esplosi i grandi riot. Per ora, solo nelle prigioni. Domani, chissà.
 Mentre scrivevamo, era giunta la notizia che a Modena un detenuto era morto, poi i morti erano saliti a tre e c’era un ferito grave, poi i morti erano diventati sei, poi sette, infine otto. Tre morti anche a Rieti. A Pavia venivano presi in ostaggio due agenti di custodia. A Foggia c’era stata un’evasione di massa.
Mentre scrivevamo, era giunta la notizia che a Modena un detenuto era morto, poi i morti erano saliti a tre e c’era un ferito grave, poi i morti erano diventati sei, poi sette, infine otto. Tre morti anche a Rieti. A Pavia venivano presi in ostaggio due agenti di custodia. A Foggia c’era stata un’evasione di massa.
Il 10 marzo era esplosa anche la Dozza. Centinaia di detenuti si erano impadroniti del reparto giudiziario. Verso sera, compagne e compagni avevano raggiunto il carcere ed esposto uno striscione con la scritta «Amnistia subito! Liber* tutt*!». A quel punto, le autorità non avevano più fatto passare nessuno. Noi c’eravamo arrivati solo perché Wu Ming 2 conosceva ogni cazzo di sentiero e cavedagna dei dintorni.
Da decenni in Italia non si vedevano rivolte carcerarie tanto vaste e radicali. I detenuti erano i primissimi a rivoltarsi apertamente contro la gestione dell’epidemia sulla pelle dei più deboli e dei già esclusi.
La cosa più sensata da fare, e (in un paese diverso) realizzabile subito, l’aveva enunciata con la massima chiarezza Luca Abbà:
«liberare chi già gode di benefici, chi è sopra una soglia di età definita “a rischio”, chi ha un residuo di pena sotto i due anni. Non sta a me proporre quali misure alternative si potrebbero applicare (tipo obblighi di firma, rientri domiciliari ecc…) e nemmeno la forma legislativa adeguata (amnistia, indulto, decreto legge). Ai detenuti esclusi da tale provvedimento si potrebbero applicare più facilmente misure di prevenzione e sicurezza adeguate per poter garantire i colloqui con i propri cari e condizioni di detenzione meno disagiate di quelle odierne a causa del sovraffollamento cronico degli ultimi anni.»
⁂
I detenuti non si erano fatti paralizzare dal timore di essere criminalizzati: stavano già in gaiba, più di così…
Fuori, per esser messi alla gogna e additati come delinquenti bastava esprimere un minimo scetticismo sulla gestione dell’emergenza.
Sui social circolava la solita memetica e “satira” fascistoide, in cui si dava la colpa dell’epidemia a vari capri espiatori: gli «italiani che se ne fottono delle regole», la fauna della «movida», un pingue e sudicio attivista con la bandiera della pace… Ma anche in questo caso, a fomentare erano i media mainstream, con gli articoli contro i presunti «furbetti della quarantena».
C’era un chiaro desiderio di «maniere spicce», di uno stato autoritario che facesse «pulizia».
Tanti dicevano che la Cina ce l’aveva fatta perché lì c’era un regime, una dittatura.
Altri blateravano di responsabilità collettiva e di «proteggere i più deboli», quando fino al giorno prima avevano incensato la meritocrazia, il darwinismo sociale e chissenefotte delle persone più fragili.
Più sottile, l’accusa di «sminuire l’emergenza».
A noi sembrava che quell’accusa andasse rovesciata.
Sminuiva l’emergenza chi accusava gli altri di sminuire l’epidemia.
Sminuiva l’emergenza chi la confondeva con l’epidemia.
Sminuiva l’emergenza chi voleva parlare solo del virus, del numero dei contagiati, del «bollettino di guerra» strettamente sanitario ecc.
La fallacia era parlare di provvedimenti politici drastici e senza precedenti, di misure di governance con ricadute sociali a cascata, come se fossero procedure cliniche. Lo spettacolo di una «medicalizzazione della politica» era messo in scena giorno e notte, tramite l’insistenza su mascherine e ingressi di ospedali. E se non ti adeguavi a quel modo di parlare dell’emergenza, ti accusavano di «sottovalutare la situazione».
Colpa di un equivoco di fondo, un malinteso concettuale che ci vedeva reciprocamente lost in translation.
C’era chi per «emergenza» intendeva il pericolo da cui l’emergenza prendeva le mosse, cioè l’epidemia.
Invece, noi e pochi altri – in nettissima minoranza ma in continuità con un dibattito almeno quarantennale – chiamavamo «emergenza» quel che veniva costruito sul pericolo: il clima che si instaurava, la legislazione speciale, le deroghe a diritti altrimenti ritenuti intoccabili, la riconfigurazione dei poteri…
Chi, ogni volta che si parlava di tutto ciò, voleva subito tornare a parlare sempre e solo del virus in sé, della sua eziologia, della sua letalità, delle sue differenze con l’influenza ecc., a nostro parere sottovalutava la situazione.
Qualcuno, poi, accusava a vanvera di «negazionismo».
Noi stessi, pur non avendo mai negato la pericolosità del virus e l’esistenza dell’epidemia, ci eravamo beccati l’epiteto «negazionisti epidemiologici».
Beh, c’eravamo abituati.
Con calma, ci sarebbe stato da riflettere su quanto l’accusa di «negazionismo del coronavirus» avesse in comune con quella, altrettanto farlocca, di «negazionismo delle foibe».
In ogni caso, l’uso a cuor leggero del concetto di «negazionismo» faceva danni: inflazionando il termine e rendendo l’accusa passepartout, si toglieva l’erba sotto i piedi a chi cercava di contrastare i negazionisti veri: quelli dei crimini nazifascisti e quelli del cambiamento climatico. Che, tra l’altro, sovente coincidevano.
⁂
In un commento su Giap, Wolf aveva scritto:
«È almeno dal 92-93 che non disponiamo più di un tempo ordinario, una qualche emergenza c’era sempre, come minimo quella farlocchissima dei “conti pubblici”; […] non riconoscere l’emergenza permanente in cui siamo immersi è, come minimo, sintomo di una totale mancanza di senso storico.»
Sempre Wolf, in un altro commento, aveva invitato a ponderare le somiglianze tra la retorica sull’epidemia e quella che aveva preceduto la nomina e l’insediamento del governo Monti.
E così c’eravamo accorti del parallelismo tra dati sul contagio e «spread». Anche nel 2011 si era percossa, martellata l’opinione pubblica con cifre decontestualizzate, facendo crescere la paura dell’irreparabile, finché non c’era stato un quasi-coup d’état pilotato dall’UE per disarcionare il Berlusca e insediare Monti.
 Ma in realtà l’emergenza permanente era cominciata prima, nella stagione delle leggi speciali sul terrorismo. A fine anni Novanta ci avevamo pure scritto sopra un libro, Nemici dello Stato. Criminali, «mostri» e leggi speciali nella società di controllo (Derive Approdi, 1999).
Ma in realtà l’emergenza permanente era cominciata prima, nella stagione delle leggi speciali sul terrorismo. A fine anni Novanta ci avevamo pure scritto sopra un libro, Nemici dello Stato. Criminali, «mostri» e leggi speciali nella società di controllo (Derive Approdi, 1999).
Prima del Covid-19, eravamo convinti che la critica dell’emergenza fosse ormai patrimonio dei movimenti. Una consapevolezza più acuta in alcuni attivisti e più vaga in altri, anche astratta volendo, ma in ogni caso presente.
Eravamo anche convinti che le ricette di organizzazioni internazionali come l’OMS, il Fondo monetario, il WTO, l’UNESCO, la FAO non venissero prese ipso facto come Vangelo.
E invece.
Molti che negli anni, dentro i movimenti sociali, non avevano lesinato discorsi (e retorica) sull’emergenza come metodo di governo, di fronte all’emergenza coronavirus balbettavano e sembravano sguarniti di strumenti critici, affannati e pavidi di fronte a eventuali accuse di «irresponsabilità», poco o per nulla desiderosi di «spazzolare contropelo» i discorsi dominanti. E lo stesso di fronte alla tracotanza di qualunque «esperto» o ai comunicati dell’OMS.
Qualcuno andava oltre, mostrandosi proprio infastidito dal pensiero critico.
Da lì le accuse di stampo perbenista, rivolte anche da parte di “insospettabili” a chi nonostante tutto cercava di esercitarlo, il pensiero critico, per bene o male che gli riuscisse, e non rinunciava alla parresìa, al parlar franco, anche rischiando attacchi e impopolarità.
A saltare per prima era stata la capacità di comprendere i discorsi altrui. «Se fai il paragone con l’influenza», aveva scritto Robydoc su Giap, «poi devi specificare che non è un paragone epidemiologico: è come se stessi facendo il paragone con i morti sul lavoro.»
Eh, già. «Numquam nominare influentiam», precetto di stretta osservanza burioniana. Chiunque avesse detto cose ovvie sul fatto che, sotto l’aspetto sintomatico, la maggior parte dei pazienti che s’accorgeva di avere la malattia la viveva come un’influenza più aggressiva, aveva scatenato reazioni pavloviane e s’era beccato epiteti. RobyDoc proseguiva:
«Se dici che “non sembra sia il virus in quanto tale che uccide, visto che deve agire a certe condizioni per essere pericoloso”, devi specificare che questo non significa “tanto non toccherà a me”; se metti in rilievo l’insensatezza e la contradditorietà di alcuni provvedimenti, poi devi specificare che non stai proponendo di andare a vedersi la partita, eccetera.»
Chi non aveva reagito come sopra, spesso aveva scelto l’autocensura, per non passare come «quello che sminuiva», il «negazionista», il «dietrologo» (!) e quant’altro.
Forse con il decreto serale del 9 marzo qualcuno avrebbe cominciato ad aprire gli occhi.
⁂

Giorgio Agamben
Giorgio Agamben, più di chiunque altro, aveva subito il tiro al piccione, per un suo articolo uscito su Il manifesto.
Agamben si era espresso male e frettolosamente parlando del virus vero e proprio (ancora una volta l’eziologia, alla quale si sarebbero voluti confinare tutti i discorsi!), ma nelle righe sull’emergenza il suo monito era stato: attenzione, la situazione di questi giorni dimostra che, dal punto di vista del controllo e del disciplinamento sociale, sfruttando un’epidemia si può ottenere di più e molto più in fretta che sfruttando altri pericoli. E aveva fatto l’esempio del terrorismo.
Esempio ripreso anche da Mattia Galeotti su Giap, ma in un modo che poteva essere d’ispirazione e al tempo stesso aiutava a ribadire la differenza tra pericolo ed emergenza.
Nella Francia di fine 2015, dopo il massacro al Bataclan e gli altri attacchi del 13 novembre, il pericolo terrorismo era reale: le stragi c’erano state. Ma l’emergenza terrorismo era una superfetazione, era tutto il «di più» costruito sul pericolo reale: la legge marziale, lo stato di polizia, il divieto di manifestare ecc.
Scetticismo e critiche si erano diffusi tra i francesi fin da subito, ma, come aveva scritto Galeotti, non poteva bastare «la semplice evidenza dell’insensatezza [di divieti e restrizioni]», perché erano altrettanto diffusi la paura e il precetto «non è il momento di criticare».
«A un certo punto però qualcun* ha detto qualcosa di completamente diverso. È cominciato molto piano con le manifestazioni dei migranti e con la contestazione della COP21: alcune manifestazioni non autorizzate hanno violato i divieti a partire da un rifiuto dell’emergenza («la vera emergenza è il clima», uno slogan di quei giorni). Stiamo parlando del finire del 2015, ma quei giorni sono stati importanti per aprire il ciclo in cui l’Esagono si trova anche adesso. Così come è stato fondamentale che il movimento contro la Loi Travail dell’anno successivo de-sacralizzasse Place de la Republique, che era all’epoca diventata un simulacro di unità nazionale, con la statua piena di candele e frasi strappalacrime. Destituire l’emergenza è un’operazione che in Francia è riuscita.»
L’état d’urgence giustificato col pericolo del terrorismo era stato sfidato e disarticolato dal basso, dall’avvio del ciclo di mobilitazioni politiche e sindacali partito allora e che durava ancora nel 2020.
I milioni di persone che avevano infranto i divieti non erano «negazionisti», gente che non credeva all’esistenza dell’ISIS. Era gente che contestava ciò che si voleva imporre sfruttando il pericolo rappresentato dall’ISIS.

Ci avevano spesso accusati di ottimismo. In passato, bastava che constatassimo «in Italia le lotte ci sono» e molti: – Uh, come siete ottimisti…
Semplicemente, non ci eravamo mai abbandonati a fatalismo e melancolia. E chissà se era ottimismo pensare che, nonostante tutto, l’emergenza fosse contrastabile, disarticolabile, e lo stato d’emergenza destituibile, e che il conflitto reale sarebbe tornato a manifestarsi.
⁂
Eravamo stati attaccati per avere scritto, nel Diario virale #1, quel che in realtà avevano scritto anche svariati esperti e rispettati divulgatori, e che il sito Scienza in Rete aveva così riassunto:
«Quello che si DEVE dire è, sic et simpliciter, che molti di quelli che incontrano il virus nemmeno se ne accorgono. Di quelli che manifestano sintomi, solo una percentuale minima, forse il 2% o 3% (alla fine dell’emergenza saranno anche meno) ci lasciano le penne; un numero che certamente si vorrebbe, e dovrebbe, evitare, ma che va considerato nella sua giusta dimensione […] Per essere ancora più chiari: non è né la febbre gialla né il vaiolo, e non è nemmeno la MERS, né la SARS (queste ultime due condizioni sono causate da altri coronavirus). Se lo si dicesse chiaramente, ribadendo il concetto che questa letalità, unita alla finora bassa probabilità di contagio individuale, produce un rischio individuale nullo per chi non si trova in zona ad alta densità di contagio […] si eviterebbero le code ai supermercati per comperare 50 scatolette di tonno, 6 flaconi di amuchina o 50 bottiglie di acqua.»
E invece, come già avevamo fatto notare, altri esperti – magari per vendere un instant-book con prima tiratura da centomila copie – alla chiarezza preferivano l’allarme indiscriminato, fino a lanciare strali contro chi, già guarito, usciva di casa, dando così un presunto «segnale sbagliato».
C’erano poi vari modi di giustificare le misure prese, trasformando in Sacre Scritture studi dagli esiti dichiaratamente incerti e sfumati.
Mai come in quei giorni s’era visto che la comunicazione scientifica si presentava come «neutra» ma era inzuppata di ideologia dominante, come ogni altra comunicazione, e presa nelle contraddizioni del reale. Ne aveva scritto su Giap Mariano Tomatis qualche anno prima, e in quell’occasione c’era stato un bel dibattito.
Ma gli ultimi in grado di rendersene conto sembravano essere gli scienziati. Il Patto Trasversale per la Scienza concludeva così il suo comunicato congiunto sull’emergenza Coronavirus:
«è importante ribadire che non c’è nessun disaccordo tra scienziati, in quanto le nostre valutazioni ed i nostri obiettivi sono comuni. D’altronde non potrebbe essere altrimenti tra persone che sanno dove iniziano i fatti e dove finiscono le opinioni.»
Seguivano le firme di importanti luminari e professori ordinari (tutti rigorosamente maschi), della cui competenza specifica non potevamo discutere. Tuttavia, se la loro preparazione epistemologica e filosofica era quella che emergeva dall’ultima frase, condita peraltro da un’insopportabile presunzione, non c’era proprio da stare allegri.
⁂
Come aveva notato l’urbanista Enzo Scandurra, l’epidemia aveva mostrato la fragilità della costruzione neoliberista:
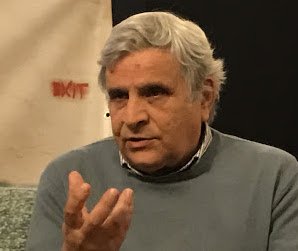
Enzo Scandurra
«La ridondanza e la flessibilità assicurano che se una parte del sistema va sotto stress (per es. il fegato nel caso del sistema-uomo) altre parti del sistema collaborano per attenuare lo stato di stress del sottosistema. I sistemi viventi sono infatti sistemi ridondanti e con notevoli caratteristiche di flessibilità […] la flessibilità è il contrario della specializzazione. Tanto più un sistema è specializzato, ovvero basato su un’unica variabile o sull’uso spinto di una tecnologia, tanto più sarà fragile e non capace di resistere a cambiamenti imprevisti. Questo è evidente nel caso dell’Alta Velocità dove uno scambio mal progettato ha praticamente messo in ginocchio tutto il sistema dei trasporti ferroviari […] C’è allora da riflettere su come le nostre città siano sistemi dotati di scarsa flessibilità […] quando si verifica il collasso di uno dei sottosistemi (la sanità, ad esempio), l’intero sistema entra in uno stato altamente critico.»
Un esempio di parametro che aveva impedito la flessibilità e preparato il disastro era il cosiddetto «rapporto deficit-PIL non superiore al 3%», uno dei più noti dogmi neoliberali, nato in Francia nei primi anni Ottanta e divenuto una delle pietre angolari del Trattato di Maastricht (1992).
Ogni volta che si affrontava una questione seria si chiedeva la deroga a quel parametro. A riprova che era insensato. Del resto, lo aveva ammesso il suo stesso inventore.
Guy Abeille
«Se mi chiede se la regola adottata oggi in Europa […] secondo cui il deficit di un Paese non deve superare il 3% del Pil abbia basi scientifiche, le rispondo subito di no. Perché sono stato io a idearla, nella notte del 9 giugno 1981, su richiesta esplicita del presidente François Mitterrand che aveva fretta di trovare una soluzione semplice che mettesse rapidamente un freno alla spesa del governo di sinistra che nel frattempo stava esplodendo. Così in meno di un’ora, senza l’assistenza di una teoria economica, è nata l’idea del 3% […] il numero 3, che è noto al pubblico per vari motivi ed ha un’accezione positiva, si pensi alle Tre Grazie, ai tre giorni della resurrezione, le tre età di Auguste Comte, i tre colori primari, la lista è infinita. Un numero, magico, quasi sciamanico, facilmente spendibile anche nel marketing politico […]»
(Guy Abeille, intervistato dal Sole24Ore, 04/04/2019)
I dogmi neoliberisti inscritti nei trattati europei e recepiti dalle leggi italiane avevano imposto feticci come il «pareggio di bilancio», inserito perfino nella Costituzione.
Proprio l’inseguimento del «pareggio di bilancio» era quello che aveva devastato il welfare state e in particolare la sanità pubblica, che adesso, dopo quasi trent’anni di tagli, si ritrovava incapace di gestire l’epidemia.
Così avevano riassunto lo sfascio le CLAP (Camere del Lavoro Autonomo e Precario):
«Dal 1997 […] l’Italia ha perso 100mila posti letto […] Tra il 2012 e il 2017 […] sono stati soppressi 759 reparti ospedalieri.»
Ora si diceva che per affrontare l’epidemia bisognava operare in deficit di oltre sette miliardi. Una super-deroga giustificata dalla situazione.
Sì, si potevano chiedere e ottenere deroghe, ma quanto a soluzioni razionali sul lungo periodo, c’era poco da sperare.
«Il servizio sanitario è al collasso!», «i posti-letto già finiti!»… Si parlava di posti-letto e di capienza del sistema sanitario come se fossero premesse assiomatiche, un datum quasi immodificabile.
E invece, se c’era davvero grande pericolo, allora si sarebbero dovuti mettere in questione anche i dogmi più consolidati.
C’era urgenza? Allora che si precettassero le cliniche e gli ospedali privati, quelli che avevano guadagnato dall’aziendalizzazione, privatizzazione e frammentazione del Sistema Sanitario Nazionale.
Qualcuno non voleva essere precettato? Requisire la struttura. L’esproprio per pubblica utilità lo prevedeva anche la Costituzione, che quando parlava della proprietà privata ne limitava «i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale».
Nell’Italia di un universo parallelo, l’epidemia poteva essere l’occasione giusta, poteva stimolare un’inversione di rotta e il ritorno a una sanità veramente pubblica, universale e gratuita.
Ma come arrivarci, in quell’universo parallelo? Neanche a Reggio Emilia, si poteva andare.
⁂
I ruzzoloni in borsa (il 9 marzo Piazza Affari aveva chiuso a -9%) e il fatto che molti settori dell’economia fossero in sofferenza veniva usato per dire: – Avete scazzato analisi, il capitalismo non ci guadagna niente.
Chi traeva simili conclusioni non faceva altro che cadere in balia di due equivoci:
1) scambiava l’«economia» nella sua dimensione contingente per il capitalismo come sistema, e
2) confondeva il «governo» – inteso come la momentanea compagine dei politici che ricoprivano gli incarichi ministeriali – con la governance, cioè con l’insieme di strumenti atti ad assicurare la stabilità dei rapporti tra governanti e governat*.
Più o meno lo stesso errore di quando si confondeva «il tempo che fa» con il clima, e si diceva: – Oggi fa freddo, dove sarebbe questo riscaldamento globale, eh?
L’emergenza consentiva una vastissima speculazione finanziaria.
Dall’emergenza estraevano valore le grandi piattaforme, come Google che ne approfittava per prendersi sempre più pezzi di scuola pubblica.
Dell’emergenza approfittava l’industria dell’intelligenza artificiale applicata a sorveglianza e controllo, dalle videocamere smart alle nuove macchine biometriche da usare nei checkpoint ai termoscan che si stavano installando anche nei nostri aeroporti e nelle nostre stazioni, fino ai droni progettati ad hoc per i cordoni sanitari. E come si fregavano le mani gli organizzatori della più grande expo del settore, la iHLS InnoTech Expo, che si sarebbe tenuta a Tel Aviv a novembre:
«Interested in learning more about the applications of robotics and AI in emergency and disaster scenarios? Attend iHLS InnoTech Expo!»
Sul sito dell’expo c’erano vari articoli dove si parlava dell’emergenza coronavirus. Uno, ad esempio, la descriveva come una grandissima opportunità per vendere ai governi droni di ultima generazione.
L’emergenza permetteva anche di dividere, riconfigurare e controllare meglio i territori, stabilendo quali fossero sacrificabili e quali no.
Prima che l’intera Lombardia diventasse «zona arancione» e poi tutto il Paese «zona protetta», c’era stato, per dirla con Zone Rosse su Giap:
«un tentativo di riconfigurare la geografia nel senso di un controllo del territorio che consentisse a Milano e al polo logistico di Piacenza di funzionare a “regime coronavirus” […] sacrificare le province di Cremona e Lodi e parte della bergamasca per non compromettere la finanza, il flusso della logistica e l’asse Milano-Venezia.»
Nelle Marche, si era deciso di “dedicare” al Coronavirus l’ospedale di Camerino – al centro di un territorio fragile, che già da quattro anni viveva l’emergenza terremoto, senza nemmeno i medici di famiglia in molti paesi. I ricoverati erano stati trasferiti a San Severino e Macerata, i lungodegenti a Cingoli.
Ma anche dai territori “sacrificati” si poteva estrarre valore. Wolf aveva attirato la nostra attenzione su certi discorsi:
«stamattina alla “voce del padrone” [Radio24, N.d.R.] un deputato della Lega che si trova in zona rossa (non ricordo il nome, ma poco importa) proponeva la trasformazione delle zone rosse in ZES, zone economiche speciali, cioè territori in cui si deroga a normative fiscali, del lavoro, ambientali… a favore delle imprese.»
Si stavano facendo ipotesi ed esperimenti. Caoticamente, alla carlona, scherzando con la catastrofe, ma intanto si insinuavano idee, scenari fino ad allora impensabili diventavano pensabili, e qualcosa sarebbe tornato utile.
Toccava ribadirlo: la funzionalità dell’emergenza non era la messa in pratica di alcun complotto o Piano perfetto o bella pensata o Volontà del Signor Capitale, ma era una funzionalità sistemica, parte dell’operatività strutturale del capitalismo, ed era sempre l’esito di contraddizioni e conflitti.
⁂
Per tornare sulle cause sistemiche delle nuove epidemie: da tempo si preconizzava che il surriscaldamento globale, sciogliendo il permafrost, avrebbe “risvegliato” virus coi quali noi umani non eravamo mai entrati in contatto.
Avremmo reagito ogni volta come con questo coronavirus?
O avremmo finalmente deciso di farla finita con il capitalismo?

La Dozza in fiamme, foto di Wu Ming 2.
In mezzo al campo arato osservavamo il fumo salire denso dal carcere e perdersi nella notte. Sentivamo le urla, gli scoppi dei lacrimogeni, le sirene. Tutto intorno a noi un paesaggio da horror rurale; in lontananza la basilica di San Luca, sempre illuminata; e più vicino, le luci del quartiere fieristico.
Quel lembo di terra era ancora Bulåggna, ma non lo era già più. Da quella spianata rischiarata dalla luna guardavamo l’immagine mostruosa del paese riflettersi nelle fiamme. Non sapevamo cosa ci aspettava, ma potevamo immaginarlo. Ci sentivamo grati di essere lì, l’uno per l’altro. Urticati, infangati e forse perfino fuori tempo massimo per saltare canali, ma c’eravamo. Non da soli.
Saremmo andati a cercare chiunque non avesse ancora ceduto all’insensatezza. Questo ci avrebbe dato la forza nei tempi a venire. Come sempre.
E avremmo scommesso ancora sull’intelligenza contro l’idiozia di stato, la paranoia collettiva, la politica emergenziale. Una volta di più. Un minuto di più.
In fondo, non c’era mai stato un motivo più valido per fare ciò che andava fatto.