
Le mascherine erano pantomima, non prevenzione. La maggior parte della gente lo aveva capito, oppure prevaleva il timore del ridicolo: era pur sempre una città che amava stare in ghingheri. Fatto sta che le mascherine si vedevano quasi solo sui giornali e sui siti dei giornali.
Nei primi giorni, si era trattato sempre di operatori sanitari, infermieri, gente che lavorava in ospedale, poi erano arrivate a valanga le foto dal presunto “shock value” (oooooh!): tizi con la mascherina davanti al Duomo di Milano o in altri luoghi famosi.
A Bologna, l’edizione locale di Repubblica mostrava ogni giorno foto di qualcuno che girava sotto i portici con la mascherina. Per la verità, era sempre un fagiano isolato, attorniato da altre e altri che non la indossavano e forse lo compativano.
 Eppure Chiara, che lavorava in farmacia, ci raccontava di quante persone entravano e le chiedevano mascherine, dopo aver superato almeno cinque cartelli che avvisavano del loro esaurimento. Un conoscente si vantava di averne acquistate on line un pacco da dieci, per tutta la famiglia, già all’inizio di febbraio. Comprare la mascherina era un modo per sentirsi efficienti, pronti alla battaglia. Omologati e quindi più sicuri. Era il desiderio per un oggetto solo perché lo desiderano gli altri. Un mix di consumismo e paranoia. Very emiliano.
Eppure Chiara, che lavorava in farmacia, ci raccontava di quante persone entravano e le chiedevano mascherine, dopo aver superato almeno cinque cartelli che avvisavano del loro esaurimento. Un conoscente si vantava di averne acquistate on line un pacco da dieci, per tutta la famiglia, già all’inizio di febbraio. Comprare la mascherina era un modo per sentirsi efficienti, pronti alla battaglia. Omologati e quindi più sicuri. Era il desiderio per un oggetto solo perché lo desiderano gli altri. Un mix di consumismo e paranoia. Very emiliano.
La mascherina era l’equivalente individuale, personal, delle «misure di prevenzione» imposte alla cittadinanza. Non c’era bisogno di indossarla davvero. Contava il gesto: come certi eroinomani che rimangono dipendenti dal buco, anche senza iniettarsi la roba. Tornato a casa, te ne dimenticavi, la imbucavi in un armadio e tanti saluti. Pura funzione apotropaica. Un talismano. Nel frattempo, proprio facendo la coda in farmacia, potevi esserti beccato il virus. La deterrenza produce quel che vorrebbe evitare.
Nel tardo pomeriggio del 23 febbraio avevamo perlustrato due quartieri – Navile e Porto – in cerca di mascherine. Da poche ore era arrivata l’ordinanza del governatore Bonaccini, tanto perentoria quanto ambigua nelle formulazioni, anche per via di un inquietante eccetera:
«Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico […]»
Non avevano scritto «politica e sindacale», ma nell’eccetera molti avevamo letto precisamente quello. «Il 29 c’è la manifestazione per Orso in Cirenaica», si diceva nelle mailing list. «Che faranno? Mandano la Celere a caricarci in quanto “untori”?»
L’ordinanza proseguiva:
«chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza […] Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura […] nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi.»
I musei… ma non le biblioteche. Noi stessi, nei giorni seguenti, avremmo continuato a lavorare nella sala studio di una biblioteca di quartiere, piena zeppa di gente.
L’ordinanza era piena di nonsense e buchi, tanto che il giorno dopo una circolare applicativa avrebbe tentato di mettere toppe, col solo risultato di rendere la situazione ancor più contraddittoria e surreale.
Dicevamo della perlustrazione. La Bolognina era piena di gente. In Piazza dell’Unità si giocava a basket e si chiacchierava a capannelli, come sempre. Lì accanto, il supermercato Pam era aperto e affollato, come al solito. Nessuno faceva incetta nevroticamente, nessuno portava la mascherina. C’erano scaffali semivuoti, ma la domenica sera succede sempre.
Giusto il ristorante cinese, la sera prima, aveva un aspetto diverso. In un sabato normale, era impossibile trovare un posto a sedere senza aver prenotato. Invece, in tutto il locale, i clienti occupavano soltanto due tavoli.
In compenso i cinesi erano dappertutto, com’era normale in Bolognina, e nessuno che li scansasse o gridasse loro qualcosa. L’emergenza sanitaria non faceva diventare razzista o sinofobo chi non lo era. Semmai, faceva emergere un razzismo pre-esistente, che usava il virus come pretesto per sfogarsi.
Un tramonto di una bellezza da restare attoniti tingeva il cielo di scarlatto e carminio, per contrasto facendo sembrare nera la stazione vista dal ponte Matteotti, e trasfigurando tutto il mondo intorno. Il giorno dopo, avremmo rivisto quei colori su Repubblica on line, a far da sfondo per posti di blocco e gente in mascherina, come nella locandina di un film apocalittico di serie B.
A nord del ponte, la Bolognina; a sud, via Indipendenza saliva fino al Nettuno. Eravamo entrati in stazione ed era affollatissima, zero mascherine anche lì. Avevamo incontrato De Bellis, una vecchia conoscenza, e scambiato due chiacchiere sulla psicosi da coronavirus… ma intorno a noi non ce n’era traccia.
Normalità anche dentro il Despar della stazione, niente incetta, c’era chi comprava solo tre birre, un sacchetto di Fonzies… Intorno a piazza Medaglie d’oro i soliti bar, le pizzerie al taglio, le gelaterie… Tutto come di consueto.
Via Indipendenza, via dei Mille, Piazza dei Martiri, via Marconi… Là in alto, la sagoma scura di Villa Aldini. Moltitudine di corpi a passeggio. Bambine e bambini tornavano in costume da feste di carnevale, coi loro genitori.
Genitori tranquilli e sorridenti. Eppure, come appurato direttamente e da testimonianze altrui, le chat di genitori – il vero inferno del dark web contemporaneo – erano in preda alla pazzia, sature di un vero e proprio desiderio di fascismo profilattico, e di terrore per le sorti dei bambini.
L’allenatore di uno sport di squadra, per ovviare alla chiusura della palestra, aveva proposto ai ragazzini di trovarsi in un parco, visto il caldo primaverile. Una madre gli aveva risposto sottolineando il passaggio dell’ordinanza regionale che vietava l’aggregazione in luoghi pubblici e privati.
Eppure, in nessuna parte del mondo, nemmeno a Wuhan, risultavano morti minorenni, anzi, sembrava proprio che al nuovo virus i bambini fossero quasi immuni.
Forse anche chi rovesciava nelle chat quell’ansia e quella furia, dopo, per strada, si comportava da persona raziocinante. Anche quello era un gesto apotropaico. Uguale e contrario a quello di chi sosteneva che il virus era solo una barzelletta e sfornava calembours, si dava alla memetica spinta, cazzeggiava a getto continuo. Il cinismo e la paranoia vanno a braccetto, si nutrono della stessa sfiducia, dello stesso rifiuto per qualunque chiave di lettura del mondo. Senza chiavi, non entri più da nessuna parte. E se ti scappa da cagare, puoi solo cagarti addosso.
In ogni caso, se uno non avesse avuto lo smartphone, girando per le vie non si sarebbe accorto di nulla. Cosa dovevamo concluderne?
Forse che, almeno a Bologna, la paranoia era in gran parte confinata alla sfera mediatica-social.
A essere paranoica e ansiogena era stata per prima l’informazione mainstream. In seconda – ma rapidissima – battuta quel mood si era impossessato della classe politica, degli amministratori locali e di una minoranza di persone comuni. Sì, almeno da noi, sembrava proprio una minoranza: persone perlopiù attempate e sole, che credevano alla tv o a Facebook e si precipitavano in farmacia per accaparrarsi l’amuchina.
Si stava generando un grande paradosso: la Regione Emilia-Romagna disponeva la chiusura di (quasi) tutti i luoghi di cultura e socialità, quelli dove si sarebbe potuta elaborare insieme l’emergenza – scuole, musei, teatri, cinema – e vietava le manifestazioni con un «ecc», mentre la gente continuava ad ammassarsi nelle stazioni e nei luoghi del consumo.
I centri commerciali e i supermercati funzionavano as usual. Quel pomeriggio Jadel era stato all’Ikea e riferiva del sempiterno marasma di corpi che avanzavano a serpentone, tra camerette di bimbi virtuali e tinelli abitati da spettri di famigliole. Bruno era passato all’Ipercoop Lame: piena zeppa. Nelle palestre – le vedevi attraverso le vetrate che davano sui passeggi – ci si allenava come al solito: si sudava, ci si respirava l’alito a vicenda, ci si spogliava e si faceva la doccia negli stessi vani.
Sia chiaro, non stiamo dicendo che dovevano chiudere anche quelli: al contrario, facciamo notare che lo scopo dell’ordinanza non era la profilassi. Stante quella situazione, che profilassi vût mâi fèr?
Le strombazzate chiusure erano sanitariamente inutili, com’era stato inutile bloccare i voli, mettere posti di blocco sulle strade, far camminare avanti e indietro poliziotti e militari in mimetica.
L’Italia era stata l’unico paese europeo a bloccare i voli dalla Cina. Null’altro che teatro, oltreché un contentino agli idioti e mestatori che sbraitavano: «Chiudere le frontiere!» Un provvedimento facilissimo da capire, ma di nessuna utilità, anzi, controproducente.
A ogni epidemia si facevano le stesse cose, col pilota automatico, e ormai c’erano studi su studi a dimostrare che non servivano o facevano proprio danni.
Nel 2003, in piena epidemia di SARS, il Canada aveva sperperato oltre 7 milioni di dollari in controlli di passeggeri in arrivo… senza trovare un solo contagiato. Quei soldi, avevano concluso gli autori di uno studio apparso sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases, sarebbe stato meglio investirli direttamente nella sanità.
 Sei anni dopo, in pieno allarme da influenza «suina», l’Australia aveva fatto la stessa cosa: aveva militarizzato otto aeroporti e controllato quasi due milioni di passeggeri in arrivo o di ritorno nel Paese. Il tutto per identificare solo 154 persone che forse avevano l’influenza in forma lieve. Anche in quel caso, a detta di chi aveva analizzato la vicenda, si erano sprecate preziose risorse, sottraendole alla sanità.
Sei anni dopo, in pieno allarme da influenza «suina», l’Australia aveva fatto la stessa cosa: aveva militarizzato otto aeroporti e controllato quasi due milioni di passeggeri in arrivo o di ritorno nel Paese. Il tutto per identificare solo 154 persone che forse avevano l’influenza in forma lieve. Anche in quel caso, a detta di chi aveva analizzato la vicenda, si erano sprecate preziose risorse, sottraendole alla sanità.
Lo stesso sfoggio di inutilità si era avuto con l’aviaria, con Ebola e, in Cina negli ultimi due mesi, con lo stesso Covid 19.
Pure in Italia stavamo assistendo a un gigantesco sperpero di soldi pubblici, spesi in militarizzazione, posti di blocco e pattugliamenti vari anziché usati per potenziare la sanità pubblica – indebolita da trent’anni di «aziendalizzazione», tagli, esternalizzazioni – per renderla in grado di affrontare un acuirsi della crisi.
Anche l’efficacia sanitaria dei “lockdown” territoriali, cioè delle quarantene di massa, era messa in discussione da diversi studi. Per quanto fosse controintuitivo, alcune ricerche sembravano dimostrare che i lockdown delle zone ad alto rischio aumentavano il numero di contagi e l’estensione dell’epidemia.
No, la profilassi – almeno quella in senso stretto – c’entrava poco, come con le mascherine.
⁂
«Chiudere tutto» aveva una finalità a breve termine diversa da quella sbandierata, e poi aveva una funzione sistemica, oggettiva, a lungo termine, di cui Bonaccini e la sua giunta – e i loro omologhi di altre regioni – erano solo esecutori semiconsapevoli.
La finalità a breve termine era fare teatro: esibire «prontezza» e «nerbo» a favore di telecamere, mostrare che «si stava agendo», poco importava se a cazzo di cane e senza costrutto, l’importante era agire, subito! «Subito» era la parola magica: «Bravo Bonaccini che si è mosso subito!» . L’altro concetto virale era: «Meglio troppo che troppo poco». Seguivano i like.
La rappresentazione più plastica di quell’atteggiamento l’aveva fornita il governatore della Regione Marche, che parlando in conferenza stampa, aveva prima annunciato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, per rimangiarsi il provvedimento seduta stante, dopo aver ricevuto in diretta una telefonata dal governo nazionale.
Le decisioni drastiche servivano giusto a pararsi il culo e a stendere un velo sul solito pressapochismo.
La funzione sistemica, invece, aveva a che fare con la biopolitica, con il governo dei corpi e il controllo della popolazione. Come ogni “emergenza” pompata e montata, anche questa tornava buona per stabilire un precedente.
«Chiudere tutto» – o meglio, fingere di chiudere tutto – non serviva a niente, ma non appena la situazione fosse migliorata, i politici avrebbero dato il merito ai provvedimenti. Il tran tran sarebbe ricominciato, ma con più controllo di prima, più sorveglianza, e con l’idea condivisa che da un giorno all’altro si poteva bloccare la cultura, vietare ogni riunione, associazione, “assembramento” di persone non finalizzato al mero consumo, col consenso di un’opinione pubblica impaurita («Qualcosa si deve pur fare!»). O meglio: col consenso dei media e di una minoranza rumorosa di imparanoiati, che creavano l’effetto di un’opinione pubblica impaurita.
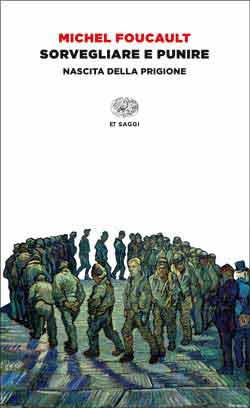 Nel suo capolavoro Sorvegliare e punire (1975), Michel Foucault aveva descritto un “lockdown” del XVII secolo:
Nel suo capolavoro Sorvegliare e punire (1975), Michel Foucault aveva descritto un “lockdown” del XVII secolo:
«Ecco […] le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città. Prima di tutto una rigorosa divisione spaziale in settori: chiusura, beninteso, della città e del “territorio agricolo” circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randagi; suddivisione della città in quartieri separati, dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è posta sotto l’autorità di un sindaco, che ne ha la sorveglianza; se la lasciasse, sarebbe punito con la morte. Il giorno designato, si ordina che ciascuno si chiuda nella propria casa: proibizione di uscirne sotto pena della vita. Il sindaco va di persona a chiudere, dall’esterno, la porta di ogni casa; porta con sé la chiave, che rimette all’intendente di quartiere; questi la conserva fino alla fine della quarantena. Ogni famiglia avrà fatto le sue provviste, ma per il vino e il pane saranno state preparate, tra la strada e l’interno delle case, delle piccole condutture in legno, che permetteranno di fornire a ciascuno la sua razione, senza che vi sia comunicazione tra fornitori e abitanti; per la carne, il pesce, le verdure, saranno utilizzate delle carrucole e delle ceste. Se sarà assolutamente necessario uscire di casa, lo si farà uno alla volta, ed evitando ogni incontro. Non circolano che gli intendenti, i sindaci, i soldati della guardia e, anche tra le cose infette, da un cadavere all’altro, i “corvi” che è indifferente abbandonare alla morte: sono “persone da poco che trasportano i malati, interrano i morti, puliscono e fanno molti servizi vili e abbietti”. Spazio tagliato con esattezza, immobile, coagulato. Ciascuno è stivato al suo posto. E se si muove, ne va della vita, contagio o punizione.»
La noncuranza per la sorte dei “corvi” – infermieri, portantini, ausiliari sanitari – accomunava quel regolamento dei tempi della peste ai giorni del Covid 19 in Italia. Pochi sembravano preoccuparsi del superlavoro in ospedali e laboratori, dei turni raddoppiati e triplicati, dell’esaurimento psicofisico del personale in un settore da tempo in sofferenza.
Perché Foucault aveva scritto di quarantena nel XVII secolo? Perché quella logica era sopravvissuta anche dopo la peste, la quarantena era rimasta come possibilità, opzione sempre praticabile nel rapporto tra pubblici poteri e corpo sociale. Quel normare lo spazio urbano, le vite e i corpi aveva aperto la strada all’affermarsi delle società disciplinari del XIX-XX secolo:
«Alla peste risponde l’ordine: la sua funzione è di risolvere tutte le confusioni: quella della malattia, che si trasmette quando i corpi si mescolano; quella del male che si moltiplica quando la paura e la morte cancellano gli interdetti. Esso prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene per effetto di un potere onnipresente e onnisciente che si suddivide, lui stesso, in modo regolare e ininterrotto fino alla determinazione finale dell’individuo, di ciò che lo caratterizza, di ciò che gli appartiene, di ciò che gli accade. […] la penetrazione, fin dentro ai più sottili dettagli della esistenza, del regolamento – e intermediario era una gerarchia completa garante del funzionamento capillare del potere; non le maschere messe e tolte, ma l’assegnazione a ciascuno del suo “vero” nome, del suo “vero” posto, del suo “vero” corpo, della sua “vera” malattia. La peste come forma, insieme reale e immaginaria, del disordine ha come correlativo medico e politico la disciplina.»
I “lockdown” del 2019-2020, inutili allo scopo dichiarato, avrebbero però rafforzato la presa del «capitalismo della sorveglianza», che realizzava una sintesi di società disciplinare e società del controllo diffuso.
⁂
In ogni caso, in Italia non c’era la peste. I pochi morti che il Covid 19 aveva fatto erano quasi tutti over 80 e già debilitati da altre patologie. Probabilmente il virus era già in Italia da settimane, un sacco di gente se l’era già preso ed era guarita, e altri se lo stavano prendendo senza entrare nei radar. Se non eri già messo male di tuo, poteva colpirti duro, ma la superavi. In fondo il quadro clinico era molto simile a quelli delle influenze stagionali – che ogni anno, solo in Italia, uccidevano ottomila persone, mentre al momento i morti accertati per Covid 19 erano solo sette (7).
I media aizzavano a trovare il misterioso «Paziente zero», ma forse non lo trovavano perché era già guarito, e sarebbe stato per sempre ignaro del proprio status di contagiato n.1.
E la ricerca del «Paziente zero» cos’era, se non un’altra manifestazione di paranoia? Paranoico è chi, anziché domandarsi «cosa?», si domanda: «Chi?» Paranoico non è chi teme un potere totalitario che tutto controlla, ma chi lo evoca e in fondo lo brama, perché sente marcire, intorno a sé, ogni autorevolezza e ogni significato.
Nel mentre gli anziani, cioè i soggetti più a rischio, senza particolari tutele, venivano lasciati in balia di un’informazione apocalittica, che li bombardava con immagini di supermercati svuotati e bottigliette di amuchina in gel ormai introvabili e preziosissime, spingendoli così a precipitarsi in un affollato centro commerciale, dov’era più probabile il contagio.
Eravamo il Paese europeo con più casi accertati, ma forse era solo perché facevamo test a pioggia. Quando in tutta la Francia, senza scomporsi, ne avevano fatti solo 800, soltanto nel Lodigiano noi ne avevamo già fatti più del doppio e richiesti ben 4000. È chiaro che in quel modo trovi ammalati. Ma i media pestavano, pestavano, pestavano, con coperture sempre più forsennate, titoli sempre più allarmistici, e sembrava la grande pestilenza del 1348.
– Che dobbiamo fare? – c’eravamo chiesti.
– Scriveremo il Decamerone!
– Anche meno. Scriviamo un diario collettivo di questi giorni.
⁂
I media mainstream erano i veri untori.
Di fronte al nuovo coronavirus, la già normalmente pessima informazione italiana aveva toccato il fondo di un nuovo abisso. Tutti i suoi soliti “tic” si erano uniti in un effetto palla di neve che alimentava la psicosi.
Anche le notizie in apparenza tranquillizzanti, responsabili, «niente panico», andavano a farcire il classico “panino”, inserite tra affermazioni e testimonianze di segno contrario.
Come sempre, poi, imperversava il ritornello sugli «esperti», unici autorizzati a illustrare la soluzione del problema. «Non facciamo politica, lasciamo parlare i tecnici!»
Ma appena i tecnici aprivano bocca, risultava chiaro che:

L’imperversante.
a) alcuni, da tempo trasformati in opinionisti televisivi e star da social network, erano ormai schiavi del proprio personaggio e delle aspettative del pubblico;
b) alla fine della fiera, le soluzioni proposte erano sempre politiche e sociali, perché fronteggiare un’epidemia con mille o diecimila posti letto in ospedale fa tutta la differenza del mondo, e investire in posti di blocco anziché nell’aumento di posti letto non è una decisione «tecnica», da esperti, ma politica, da amministratori;
c) I potenziali o sedicenti «esperti» erano migliaia e le loro spiegazioni spesso si contraddicevano, generando solo una maggiore confusione e una forte predisposizione al complottismo, perché «se fanno tanto casino, dev’esserci sotto qualcosa che non ci raccontano».
Anche le conseguenze del «chiudere tutto» erano politiche e sociali.
Pochi si preoccupavano di quanti avrebbero perso lo stipendio, e in diversi casi anche il lavoro. Al contrario, si lodavano alcuni negozianti cinesi che avevano deciso – obtorto collo – di sospendere le loro attività. Che pensiero carino! Il paternalismo verso quei «bravi cinesi» ricordava molto da vicino quello per i «bravi negri» che facevano volontariato, lavoravano gratis, si meritavano le nostre carezze.
I sindacati – tutti: confederali e di base – avevano fatto notare che le incongruenze dell’ordinanza bonacciniana mettevano a rischio un gran numero di lavoratori, soprattutto precari.
E la scelta di chiudere le scuole per un virus che non colpiva i bambini e falcidiava soprattutto anziani – i quali, di norma, non bazzicavano le aule – generava problemi a cascata. Un amico insegnante ci aveva descritto le proprie difficoltà:
«Non dare continuità alle attività didattiche in questo momento dell’anno scolastico è un problema, vi assicuro. Per i ragazzi con disabilità che seguo poi… Non vi dico. Devo cercare in questi giorni di mantenere loro una routine a domicilio che in qualche modo simuli la scuola. Banalmente, compiti che quotidianamente mi devono mandare per email… Già vivono un tempo sfasato e quasi mai sincronico con il resto del mondo… Figuriamoci in queste situazioni.»
Nel tardo pomeriggio del 24 era arrivata la circolare applicativa.
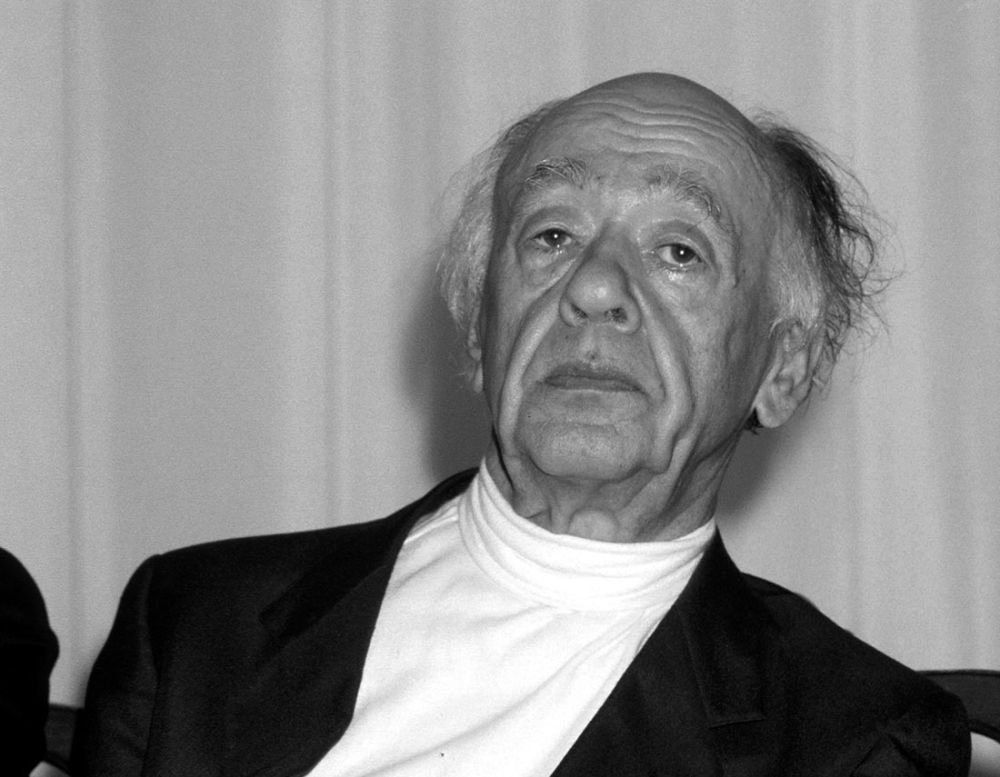
Eugène Ionesco (1909 – 1994), drammaturgo. Il più noto esponente del «Teatro dell’assurdo».
Sembrava scritta da Ionesco.
Il criterio per il quale certe attività venivano proibite e altre no sembrava essere quello – alquanto aleatorio – dell’«eccezionale concentrazione di persone». Niente manifestazioni, eventi culturali e sportivi e altre occasioni in cui si aggregava un pubblico una tantum… ma restavano aperti i mercati settimanali. E proseguiva l’attività di centri sportivi e ricreativi, centri anziani (proprio mentre svariati medici consigliavano agli anziani di restare a casa), restavano aperti gli orti urbani (dove si concentravano soprattutto anziani) ecc.
⁂
In TV e sui giornali tutti parlavano di malattia e ospedali, ma nessuno coglieva l’occasione per parlare di com’era stata compromessa la sanità pubblica italiana in trent’anni di “riforme” neoliberali.
I decreti legislativi del 1992-93 avevano introdotto criteri aziendalistici e manageriali nella gestione di ospedali e presidii sanitari territoriali: gli ospedali di rilievo nazionale o altamente specializzati erano stati sganciati dalle unità sanitarie locali e trasformati in «aziende ospedaliere»; le USL stesse – sottratte a ogni controllo da parte dei Comuni – erano divenute aziende, di diritto pubblico ma «con autonomia imprenditoriale». Quegli stessi decreti avevano anche avviato la regionalizzazione della sanità.
Di fatto, si trattava di controriforme, volte a ledere l’universalità, capillarità e gratuità del Sistema Sanitario Nazionale com’era stato istituito nel 1978. La controriforma Bindi del 1999 aveva poi implementato e accelerato ogni processo di aziendalizzazione, frammentazione, esternalizzazione, intromissione di interessi privati nella sanità nominalmente pubblica.
Le conseguenze erano state devastanti: in base alle nuove logiche di bilancio, se un ospedale non “rendeva” veniva chiuso. In tutta Italia se ne erano sbaraccati a centinaia, quasi sempre in provincia, come erano stati chiusi a migliaia i presidii di specialistica ambulatoriale. Servizi essenziali si erano allontanati di decine e decine di chilometri, in alcuni casi svanendo del tutto. Tutte decisioni prese in ordine sparso, perché la faccenda era ormai di competenza delle diverse regioni. Il servizio sanitario nazionale era da tempo poco più di una bella idea.
La scarsità di posti letto per la terapia intensiva era il leitmotiv di quei giorni di coronavirus, ma tale penuria era presentata quasi come un dato “naturale”, ineluttabile. Anziché dire che bisognava invertire la tendenza, e tornare ad aumentare servizi e posti letto, si invitava la gente a chiudersi in casa, ma anche no, dipende, puoi andare qui ma non là…
⁂
Soprattutto, nessuna talking head della TV, nessuna delle vedettes spettacolari che interpretavano il ruolo di «esperto» parlava delle cause sistemiche delle recenti epidemie, delle repentine diffusioni di nuovi virus. Farlo avrebbe comportato una critica radicale dell’aggressione capitalistica all’ambiente e al vivente.
L’aviaria, la Sars, la suina e prima ancora la BSE erano uscite dai gironi infernali dell’industria zootecnica planetaria. In parole povere: dagli allevamenti intensivi, per via di come gli animali erano trattati e, soprattutto, nutriti. Ebola, Zika e West Nile erano venuti a contatto con gli umani per colpa della deforestazione massiva e della distruzione di ecosistemi.
Anziché un’occasione per mettere in discussione il sistema che causava le epidemie, la crisi del Covid 19 era usata come diversivo per non parlare di ambiente e di clima, proprio mentre l’inverno più caldo e secco di sempre stava seminando morte. Lo aveva detto chiaro e tondo Fridays For Future Bologna:
«La città si mobilita con urgenza per l’emergenza corona virus, panico dilagante, chiusa l’università e probabilmente annullato ogni tipo di evento in settimana. Eppure a Bologna il limite giornaliero delle polveri sottili solo a gennaio è stato superato più di 11 volte, il limite giornaliero del particolato più pericoloso per la salute umana (PM 2.5), di 25 µg/m³, più di 17 volte. Ogni anno sono oltre 30.000 i nuovi casi di tumore in Emilia Romagna , circa 87 al giorno. Si stimano in media 35-40 decessi per tumore ogni giorno in regione. E come si sta procedendo? Approvando progetti per l’ampliamento della tangenziale e dell’autostrada, incrementando il traffico cittadino con una mobilità pubblica insufficiente, cara e centrocentrica. La verità che passa inosservata è che l’aria che respiriamo ogni giorno a Bologna ci uccide ma si decide lo stesso di investire sulla morte, facendo finta di niente manipolando le notizie. Perché si tace quando si tratta di crisi climatica? Perché ci sono troppi interessi in ballo!»
Qualcuno aveva fatto notare che i “lockdown” cinesi avevano fatto calare le emissioni globali di CO2, e pure da noi l’aria aveva un odore migliore. Ma era un effetto passeggero, che non aggrediva nessuna causa strutturale.
Era necessario forare la membrana di un’informazione ossessionante, porre all’ordine del giorno i problemi di fondo rimossi. Bisognava tornare a vivere e comunicare e lottare, oltre la visione di Burioni che sburioneggiava e di Giovanna Botteri che ansimava, da attrice di filodrammatica, dietro la mascherina.
Mentre riflettevamo su tutto questo il sindaco Merola aveva dichiarato:
«Bisogna applicare l’ordinanza e non perdere tempo a discutere.»
Come volevasi dimostrare.



